-
Trapani - PD apre una nuova fase politica: Valeria Battaglia eletta segretario provinciale

-
Enna - In piazza per lo stop della guerra a Gaza

-
Enna - Si festeggia il Sacro Cuore di Gesu'

-
Alcol e rischio di cancro: nuove evidenze e strategie di prevenzione

-
Innovazione nella misurazione della pressione sanguigna: un metodo più preciso per combattere l’ipertensione

-
Fermate la Terza Guerra Mondiale: un appello per la pace, prima che sia troppo tardi

-
Distretti Socio-Sanitari al collasso: Safina (PD) accusa la regione di immobilismo e ipocrisia


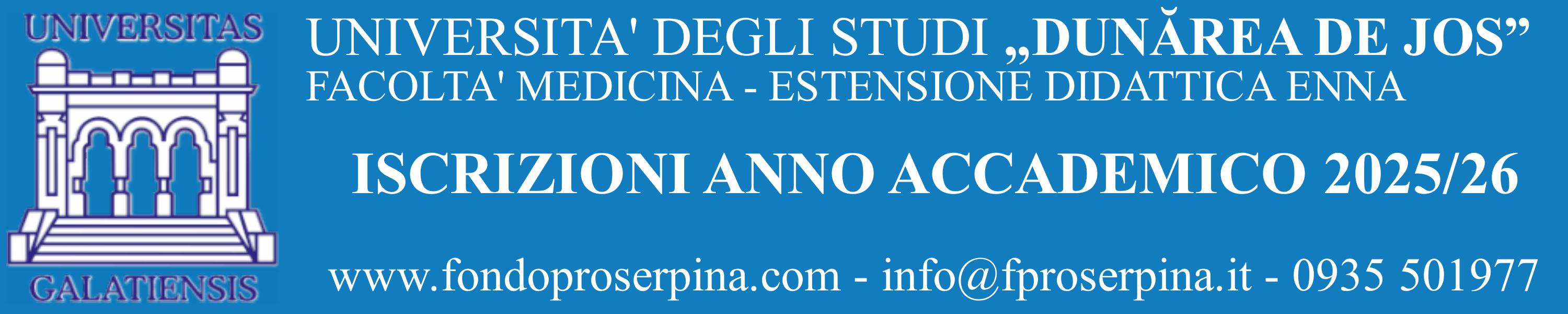
- Dettagli
- Categoria: Archeologia e Culture Antiche
Archeologia e Culture Antiche - U Diavolazzo!
Ci sono luoghi che sono sconosciuti ai più e allo stesso tempo densi di storia e di storie, libri aperti ma tuttavia rovinati dal tempo, il cui finale è tutto da indovinare. A Nicosia, generosa cittadina dell’entroterra siciliano, c’è un posto così. Già il nome tramandato in dialetto la dice lunga sul mistero del luogo a cui ci riferiamo: ‘U Diavolazzo. Si tratta delle rovine di un complesso architettonico collocato nella verde campagna nicosiana, fino a non molto tempo fa ancora in discreto stato di conservazione e oggi in stato di deplorevole degrado, che meriterebbe una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. Quel luogo, infatti, racconta una storia interessante. Siamo intorno al XII-XIII secolo: a quell’epoca Nicosia è una cittadina produttiva e fiorente sotto quel dominio Normanno che ha lasciato molte tracce nel tessuto urbano, non ultima la cattedrale dedicata a San Nicolò.
cittadina dell’entroterra siciliano, c’è un posto così. Già il nome tramandato in dialetto la dice lunga sul mistero del luogo a cui ci riferiamo: ‘U Diavolazzo. Si tratta delle rovine di un complesso architettonico collocato nella verde campagna nicosiana, fino a non molto tempo fa ancora in discreto stato di conservazione e oggi in stato di deplorevole degrado, che meriterebbe una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti. Quel luogo, infatti, racconta una storia interessante. Siamo intorno al XII-XIII secolo: a quell’epoca Nicosia è una cittadina produttiva e fiorente sotto quel dominio Normanno che ha lasciato molte tracce nel tessuto urbano, non ultima la cattedrale dedicata a San Nicolò.
Chiese e monasteri sono presenti in gran quantità e tra gli altri spicca il monastero dei Frati benedettini, annesso alla Chiesa di San Benedetto, oggi collocato nel centro urbano, ma allora posto ai margini verso la campagna. I monaci avevano prosperato a lungo in città, ma a un certo punto avvenne qualcosa, un evento inatteso o una sopraggiunta necessità, che li spinse a spostarsi. Cosa sia accaduto davvero non si sa, e i documenti finora studiati non lo chiariscono; fatto sta che questi monaci si mossero verso le campagne, pochi chilometri a sud della città lungo l’ansa del torrente Nicosia che si congiunge al fiume Salso. Quelle contrade al giorno d’oggi prendono i curiosi nomi di Ciappiere, Salinella, Pece, San Giovanni e vengono indicate col nome generico di Soccorso, in ricordo della Madonna del Soccorso alla quale in città erano dedicati diversi luoghi di culto. Si sa che quelle zone erano allora di proprietà della Chiesa, e Nicosia ricadeva ai tempi nel territorio della diocesi di Messina. Le contrade a cui abbiamo accennato erano luoghi con una intensa vocazione produttiva: in quelle zone infatti si estraevano da sempre il gesso, che è ancora visibile nei caratteristici cristalli stratificati e trasparenti, e la creta che fino a pochi decenni fa era ancora utilizzata da una fabbrica di laterizi collocata nelle vicinanze. E ancora il salgemma, dal quale lo stesso fiume Salso prende il suo nome e la pece, anticamente molto ricercata come materiale isolante e impermeabilizzante.
Sappiamo che, soprattutto nel Medioevo, monasteri, abbazie e ordini religiosi nascevano non solo per motivi religiosi, ma anche come presìdi di controllo e “civilizzazione” del territorio, nei quali si lavorava e si produceva; dei veri e propri luoghi di studio e di “cultura” nel senso più vasto del termine. La regola di San Benedetto, poi, aveva nel suo stesso motto il principio dell’Ora et Labora, la preghiera associata al lavoro produttivo. È logico dunque immaginare che questo manipolo di monaci con il voto di adempiere in terra la loro missione divina avessero deciso, più o meno volontariamente, di rendersi utili a Dio con le opere verso gli uomini, con il lavoro: attività estrattiva, gestione dei plessi minerari, trasporto e commercio dei prodotti del territorio.
Il toponimi stessi sembrano alludere alle attività che lì si svolgevano, come quello della contrada Ciappiere, dove avveniva l’estrazione dei blocchi – le ciappe in dialetto locale - di simil travertino, la cosiddetta “pietra di San Giovanni” con cui sono stati realizzati i principali edifici nobiliari di quella che era denominata “La città dei ventiquattro baroni”.
travertino, la cosiddetta “pietra di San Giovanni” con cui sono stati realizzati i principali edifici nobiliari di quella che era denominata “La città dei ventiquattro baroni”.
È dunque ipotizzabile che i monaci di San Benedetto si trasferirono in quei luoghi, li popolarono e resero utilizzabili le tante risorse presenti nella zona. Ma cosa resta oggi di quella realtà così vivace? Poco o niente per via dell’incuria e dei segni del tempo, ma è forte la suggestione delle rovine di un edificio a torretta su due livelli arroccato su uno sperone roccioso in posizione dominante rispetto all’ansa principale del corso d’acqua, di cui sono ancora riconoscibili alcuni ambienti, ma che doveva certamente essere più esteso. A pochi metri di distanza un edificio meglio riconoscibile, una piccola chiesetta ormai priva di copertura, ma sulle cui pareti sono ancora visibili affreschi di raffinata qualità in bianco su fondo giallo che sembrano imitare gli stucchi e che rappresentano strutture architettoniche con lesene e capitelli che inquadrano lo spazio delle pareti, all’interno delle quali campeggiano figure sia fantastiche che reali.
Ma come mai un luogo di carattere religioso porta il curioso nome di Diavolazzo? La risposta non è nota, ma sappiamo che il luogo fu abbandonato a un certo punto, tra il XV e il XVII secolo; forse dovette venir meno il monopolio della produzione e distribuzione delle risorse minerarie da parte della diocesi e quindi non ebbe più senso il presidio della zona. A quel punto è probabile che il sito sia stato abbandonato e, isolato e arrocato com’era, intorno ad esso siano nati racconti e leggende di vario genere. Purtroppo le notizie attualmente reperibili sono davvero scarse e solo un’indagine accurata potrebbe chiarire le caratteristiche del popolamento dell’area facendo allo stesso tempo luce sulle dinamiche socio-economiche di quella parte della Sicilia in epoca medievale e moderna.
Ringrazio sentitamente per la consulenza e la guida ai luoghi il gentilissimo Francesco La Greca, accompagnatore turistico appassionato e sensibile che conosce approfonditamente il territorio di Nicosia e che mi ha condotto a scoprire un luogo così interessante. Ringrazio inoltre per la cortese ospitalità offertaci il proprietario del fondo in cui ricade ad oggi il monumento.
monumento.
Claudia Cacciato
Archeologia e Culture Antiche - Potrebbe interessarti anche...

Archeologia: ricercatori italo-brasiliani al lavoro sull’Eretteo di Atene
Venerdì, 06 Giugno 2025 10:15Atene - Un’équipe internazionale composta da archeologi italiani e brasiliani ha avviato una nuova e significativa campagna di ricerca sull’Eretteo, uno dei templi più emblematici dell’Acropoli di...

SiciliAntica: laboratorio di archeologia sperimentale per studenti
Lunedì, 05 Maggio 2025 12:03Leonforte (EN) - L’associazione SiciliAntica – Comprensorio Assoro, Leonforte e Nissoria ha annunciato l’avvio di un laboratorio didattico di archeologia sperimentale rivolto agli studenti, con il...

Scopri i Segreti del Passato: Al Via il 1° Corso di Archeologia di SiciliAntica
Domenica, 23 Marzo 2025 11:44La sede comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria di SiciliAntica inaugura il "1° Corso Base di Archeologia" , un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di storia e antichità....

La Rinascita della Villa Romana di Gerace: L'Impegno dell'On. Eliana Longi
Martedì, 25 Febbraio 2025 15:40Nel marzo del 2024, a seguito di una segnalazione sulla presenza di una preziosa villa romana situata in Contrada Gerace (Enna), l’On. Eliana Longi si è recata personalmente sul posto per verificare...
